 |
 |
|||

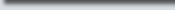
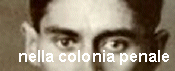
Una fonte trascurata
di Nino Muzzi
“Il selvaggio della Papuasia si tatua la faccia, copre di tatuaggi la sua barca, il suo remo, insomma tutto quello che gli capita a portata di mano. Egli non è un delinquente. L’uomo moderno, invece, che pratica il tatuaggio sulla propria pelle è un delinquente oppure un degenerato.”
Questo passo tratto da una conferenza di Alfred Loos cui sembra abbia assistito anche Kafka, si trova nel saggio “Ornament und Verbrechen” della raccolta che porta il titolo “Trotzdem”.
Di simili passi apodittici se ne trovano molti in quel saggio, e certamente Kafka deve averne trovato il tenore alquanto interessante, anche se poco convincente. Certamente covò dentro di sé questa e simili altre frasi e le lasciò maturare in tutte le loro valenze.
Nel 1914 egli scrive il racconto “Nella colonia penale” e lo legge agli amici, quindi, in sede più ufficiale, nel 1916 a Monaco presso la Galleria Goltz ad una cerchia di letterati, che non ne resta però convinta. Rilke fra i presenti nota che questo racconto non ha la stessa consequenzialità degli altri. In altri termini: in questo racconto la vittima si salva e non trionfa, così, l’ingiustizia dei padri che la voleva sacrificare.
Uno dei motivi della non-vittoria della ferocia dei padri sull’innocenza delle vittime designate sta forse proprio in questa fonte lungamente trascurata.
Un viaggiatore occidentale, una specie di reporter o forse di osservatore politico inviato dalla madrepatria in colonia, in una colonia di estremo oriente, forse nella stessa Cina, si trova ad assistere all’esecuzione di un condannato attraverso un procedimento macchinoso che lo punisce uccidendolo lentamente (circa dodici ore di morte lenta) e nel contempo istruendolo sulla propria pelle.
La macchina incide lentamente sulla schiena del condannato tramite una sorta di pantografo a mille punte il paragrafo della Legge che egli ha infranto, o forse solo un comma del paragrafo, o forse solo la parola-chiave del comma, in quanto la scrittura è talmente fitta di linee intricatissime, di ghirigori e di sboffi che prende molto spazio e la schiena del condannato potrà forse appena contenere qualche parola nel cespuglio di questo intricatissimo barocchismo grafico.
Quindi, più che di una moderna legge sembra quasi trattarsi di un comandamento arcaico: il condannato infatti sta per ricevere sulla sua schiena le parole:”Devi ubbidire”, tatuate a sangue, incise sempre più profondamente, finché la punta che scrive non sfonderà la pagina umana che ne riceve il messaggio.
Morte e illuminazione: l’occhio umano –quello laico e occidentale dell’osservatore europeo- non sa decifrare dalle matrici perforate che gli vengono mostrate nemmeno una mezza sillaba, nemmeno una lettera o una zampina di lettera in cui scorreranno gli aghi del pantografo, tatuando il dorso dell’infelice, ma l’occhio sbarrato di costui alla sesta ora di esecuzione mostrerà a chiunque lo guardi che l’uomo semitrafitto dalle punte ha capito la Legge e anche chi lo guarda negli occhi può arrivare a leggervi il comandamento ormai assimilato.
“Ci sono prigioni in cui l’ottanta per cento dei detenuti si tatua la pelle. I tatuati che non stanno in galera sono latenti delinquenti o degenerati aristocratici. Chi si tatua e muore in libertà significa semplicemente che è morto proprio alcuni anni prima di commettere un crimine.” La concezione di Loos si riduce ad un ridicolo trompe-l’oeil del genere “invidia del pene”. Infatti l’abitudine di tatuarsi, come quella d’altronde d’imparare a giocare a dama…, è spesso legata al fenomeno della reclusione: prigioni, galere, collegi, non ha però nessun rapporto causale con i motivi della reclusione stessa, ovviamente. Sarebbe come sostenere che, essendo i ricoverati in sanatorio accaniti lettori di giornale e riviste, chi legge accanitamente giornali e riviste finirà presto o tardi in sanatorio.
A Kafka non poteva sfuggire questo aspetto ridicolo e lo vediamo riaffiorare violento nell’acribia descrittiva del racconto, ma ne restava anche divertito e spaventato al contempo e quasi inceppato nel ductus narrativo.
Nel suo esitare narrativo, nella sua sospensione drammatica, nella sua acribia descrittiva egli rifiutava la classica consequenzialità che gli altri si attendevano da lui e lui da se stesso e costruiva, forse inconsciamente, una risposta di opposizione all’asseverativa stupidità di Alfred Loos.
E poi aveva un’altra fonte, dove veramente s’era abbeverato per lunghe notti insonni: “Le jardin des supplices” di Mirbeau, fonte largamente nota e analizzata dalla critica.
Si tratta di un libro scritto alla fine dell’ottocento da un sadista flaubertiano che, dotato di forte carica ironica, intellettualizza, estetizzando ed erotizzando al massimo, procedimenti di tortura di un mitico oriente raffinatissimo, di una Cina dai bordi sapienti e sbrecciati, che sta al di là delle nostre stupide, dicotomiche elucubrazioni occidentali e non distingue fra eros e thanatos, vita e morte, piacere e dolore, corpo e anima, carne e spirito e via dicendo.
Una donna, Clara, guida il viaggiatore occidentale nel giardino dei supplizi: supplizio uguale delizia.
In Kafka invece l’asse viene tutto spostato verso il supplizio-conoscenza, la morte-illuminazione (tutto il racconto si svolge sotto una canicola abbacinante). Sapere e morire si danno la mano: siamo di nuovo di fronte all’albero della scienza, di ritorno nel pensiero ebraico.
Da questa fonte Kafka trae il piacere di narrare e di scrivere. Certo la parola “piacere” forse non è la più adatta: in Kafka la scrittura è tortura, e la tortura per lui è anzitutto rivolta contro il soggetto che la pratica, se stesso. Ma è anche vendetta su chi legge, rivalsa sulla famiglia. Quindi crudeltà che dà piacere sì, ma un piacere-dolore intellettuale, non un godimento fisico o semplicemente estetico. Mentre quindi Kafka attingeva, rastremando al massimo in senso intellettivo dal Jardin des supplices (in una traduzione tedesca d’inizio secolo andata perduta), teneva d’occhio Ornament und Verbrechen per rovesciarne la logica.
La logica di Loos , abbiamo detto, si basa su di un trompe-l’oeil che altro non è se non un rapporto univoco fatto passare per biunivoco: nel rapporto univoco A dà B, ma B non dà A, la reclusione porta al tatuaggio, ma il tatuaggio non porta affatto alla reclusione.
Ora, qui sta un punto centrale della cultura mitteleuropea, cioè l’allentamento del nesso causale. Nella cultura mitteleuropea si tende a valorizzare la pluralità delle cause, la magmaticità e poliedricità dei fenomeni, l’aspetto combinatorio e casuale, la percorribilità degli eventi da destra e sinistra e da sinistra a destra. Ci troviamo spesso immersi nella fuzzy-logic del linguaggio, che tende a interpretare la Storia sovrapponendovi le proprie regole specifiche. Anche in Loos predomina questo dato per cui l’assimilazione di certi fenomeni avviene facendo leva sul linguaggio.
Alcuni fenomeni diversi come dipingersi la faccia, sporcare i muri o tracciare simboli erotici sulle pareti dei gabinetti pubblici vengono assimilati sotto il termine di ornamento, mentre la differenziazione degli stessi avviene facendo ricorso al concetto di evoluzione della civiltà, per cui al bambino come al selvaggio è permesso l’ornamento, mentre all’uomo maturo o all’epoca matura ciò non è permesso, se non a prezzo di farlo precipitare nella condizione di delinquenza o di degenerazione.
Ci possiamo quindi immaginare l’effetto che questo ragionamento poteva avere sulla mente di Kafka, con quanto sospetto egli potesse accogliere questi argomenti.
E allora, mentre scriveva, gli si levava dentro una sorta di sorda opposizione a quel ductus logico. E così, risalendo la corrente, sostenne faticosamente la tesi opposta: il delinquente lo si crea tatuandolo, designandolo tale. Ed ecco che tutto gli tornò più congeniale.
Che cosa ha fatto di male il condannato? Assolutamente niente. E’ un giovane soldato che neppure conosce la lingua, un indigeno dai tratti larghi, giocherellone come un cagnolino.
Egli avrebbe dovuto fare la guardia e salutare ogni ora davanti alla porta, come il cucù di un orologio a pendolo, ma si è addormentato. Il suo compito non era un incarico di sicurezza, bensì un semplice rituale ripetitivo: col suo sonno non ha messo a repentaglio l’incolumità di nessuno. Egli è talmente innocente che non sospetta neppure di cosa sia stato accusato, né di essere accusato, né tantomeno di essere stato condannato a morte. Come un capretto trascinato al macello soffre soltanto degli strattoni e dei legacci intorno alle giunture, ma appena questi si allentano egli riprende a giocare.
Il viaggiatore chiede all’ufficiale addetto all’esecuzione se il condannato conosce i capi d’accusa e se ha avuto modo di replicare, di presentare una difesa. L’ufficiale risponde che tutto ciò è inutile in quanto chi viene accusato è automaticamente già condannato.
Questa frase Kafka l’ha ripresa dal Jardin des supplices, ma dandole una valenza tutta kafkiana che si compendia nella formula:” Die Schuld ist immer zweifellos”.
Riprende così il gioco del potere, la sua rovinosità verso il basso: il potere della gerarchia e il potere del Passato sul Presente.
La Legge arcaica inventata da un leggendario terribile capitano sepolto nell’isola e portata avanti con rituale religioso dai suoi epigoni, suoi ammiratori e quasi adoratori, sacerdoti di una machinerie diabolica in bilico su una fossa comune, l’anonima fossa della Storia. In essa la macchina scaraventa i cadaveri tatuati a morte.
Chi visita il cimitero ebraico a Praga è colpito dalla sua collinarità: i cadaveri vi sono sepolti l’uno sull’altro fino a nove strati.
Ma c’è qualcuno che può fermare questa terribile Storia?
Ci sono le donne che possono addolcirla. Il nuovo capitano dell’isola è in latente conflitto con il vecchio terribile ivi sepolto, l’autore della Legge. Egli si circonda di donne, come un nuovo Cristo, di una schiera di stupide dame di carità che lo rammolliscono e che tentano di alleviare le ultime ore del condannato rimpinzandolo di Zuckersachen che egli vomita regolarmente una volta disteso sulla macchina insanguinata dell’esecuzione. Ciò ritarda solo di alcuni attimi la morte, in quanto questa macchina, lucente di ottoni che abbagliano sotto la canicola, deve essere ripulita da quelle sporcizie. Ma la storia dell’esecuzione deve continuare.
“Le sinfonie di Beethoven non avrebbero mai potuto essere scritte da un uomo che fosse stato solito vestirsi di seta, di velluto e di merletti. Chi oggi si aggira vestito di tuniche di velluto non è un artista, bensì un burattino o un imbianchino.”
Loos parla indirettamente di Klimt che usava portare lunghe tuniche nel suo atelier di pittore. Egli non merita per ciò che l’appellativo d’imbianchino. Ma in Klimt Loos attacca anche l’artista che più di ogni altro usava la grammatica del femminile.
E’ evidente la contrapposizione fra virile e femmineo nel pensiero di Loos, dove il ricorrente riferimento ad artisti come Beethoven o Wagner tende a forzare in termini napoleonici il corso della civiltà che si libera dal ciarpame ornamentale e marcia inesorabile verso la conquista dell’essenziale, trattenuta solo da alcuni degenerati che la tiranneggiano, consapevoli in fondo di venirne prima o poi travolti.
Kafka, nella sua rivolta, attribuisce l’ornamento proprio all’ufficiale, all’uomo apparentemente virile, deciso e sprezzatore di donne. E’ lui lo pseudo-artista che vive si esteriorità, che ammira la macchina del supplizio per quelli orpelli raffinatissimi, frutto di una fantasia tatuatrice. E’ lui il formalista ornamentale.
Nel Jardin des supplices un vecchio cinese spiega con sadica perizia le più atroci ed astruse torture ai suoi ospiti occidentali, impazienti e insieme inorriditi di udirle, e torturati dalla lentezza e minuzia del racconto. Il vecchio cinese governa tutti questi elementi di suspence con estrema abilità di narratore e gode dei volti di chi l’ascolta, torturati da orrore e curiosità. Ogni tanto controlla di sottecchi gli effetti del suo narrare sui suoi ospiti. Il gioco è estetizzante, il fine edonistico prevale, ed è il godimento dell’esercizio della tortura, reale o narrata che sia.
In Kafka il gioco si occidentalizza, acquista un aspetto etico-politico, di sistema. La machinerie kafkiana assurge subito a simbolo di una machinerie totalizzante, fondata su dei principi. Mentre le torture del Jardin des supplices sono tante e costituiscono una sorta di florilegio del supplizio, la tortura nella colonia penale è una, unica e totale: è la tortura.
Questa tortura non ha un fine né estetico né edonistico, ma etico. L’ufficiale è un intreccio di amministratore austroungarico e di ligio soldato di mistica devozione e obbedienza ai superiori. Egli non accenna un solo attimo a godere delle torture che infligge: tutta la sua opera è tesa a rendere onore a dei principi scritti su moderne tavole della Legge (le matrici del pantografo) meticolosamente conservate nei cassetti burocratici della macchina di tortura.
Se per un attimo vediamo la macchina come materializzazione di un potere supremo, fine a se stesso, che vive della propria autogiustificazione, se per un attimo ci appare nella sua anonimità e quasi innominabilità, nella sua astrattezza tutta mitteleuropea, allora possiamo capire anche il passo ulteriore del racconto, perché la macchina può colpire anche chi la manovra.
Quando, dopo svariati tentativi, l’ufficiale si accorge che il viaggiatore non vuole in nessun modo prestarsi al gioco, quando, anzi, esplicitamente costui gli rifiuta un qualsiasi appoggio, non foss’altro che con un suo avallo silenzioso all’esecuzione, allora e solo allora l’ufficiale si denuda delle sue funzioni e si sacrifica, condannandosi a ricevere il tatuaggio che la macchina riserva a chi non sa giudicare e fra mille intrecci grafici racchiude la scritta:”Sei gerecht”.
L’ufficiale allora si spoglia dell’uniforme con estrema accuratezza, ripiegando giacca e pantaloni con la cura di chi intende conservarli e invece di colpo li getta nella fossa, quindi spezza la spada e la getta giù con la guaina con tale violenza che i pezzi sbattendo in fondo alla fossa comune riecheggiano. Quindi si pone sotto il pantografo che comincia a lavorare da solo, movendosi, impazzito, in senso verticale.
“Allora il viaggiatore udì in alto, nello scrittoio, un cigolio. Levò lo sguardo. C’era dunque un ingranaggio inceppato? No, era qualcosa di diverso. Il coperchio dello scrittoio si sollevò lentamente fino a spalancarsi. Gl’ingranaggi della ruota dentata spuntarono sollevandosi, e ben presto apparve la ruota intera, come se una qualche potenza stesse premendo insieme lo scrittoio e per questa ruota non restasse più spazio: essa roteò fino all’orlo dello scrittoio, cadde giù, rotolò un pezzo nella sabbia e si fermò. Ma lassù in alto già se ne affacciava un’altra e molte altre, grandi e piccole e appena percettibili, e con tutte accadeva la stessa cosa; si pensava sempre che ormai lo scrittoio si fosse svuotato ed ecco invece uscirne un intero gruppo nuovo, particolarmente numeroso, che si affacciava, cadeva giù, rotolava nella sabbia e si fermava. (…) Era chiaro che la macchina stava andando in pezzi, il suo tranquillo procedere era un’evidente illusione.”
Questa frase più di ogni altra esplicita il pensiero di Kafka sulla monarchia danubiana: una macchina che dava l’illusione di funzionare, ma che si era svuotata di significato. E particolarmente felice è l’immagine di una potenza esterna che preme il contenitore dei meccanismi e ne provoca la disgregazione lenta e inesorabile, che vede cadere uno dopo l’altro, in una loro comica e burocratica gerarchia, tutti i meccanismi grandi e minuti: ingranaggi e gruppi d’ingranaggi che ci richiamano alla mente il gigantesco apparato burocratico dell’Austria felix.
Così la macchina movendosi all’impazzata in alto e in basso come una mascella meccanica trafigge il corpo dell’ufficiale:
“L’erpice allora si alzò di lato con il corpo infilzato, come faceva di solito alla dodicesima ora. Il sangue schizzò in mille rivoli, non misto ad acqua, anche i tubi dell’acqua questa volta non avevano funzionato. E neppure l’ultimo movimento funzionò, il corpo non si staccò dai lunghi aghi, sgocciolò l’ultimo sangue e rimase sospeso sulla fossa, senza cadervi”:
Quando il viaggiatore si avvicina alla testa dell’ufficiale infilzato per staccarlo, non può impedirsi di guardarne il volto, che non ha acquistato niente di trasfigurato, di redento, conservando invece tutta la sua espressione abituale: “le labbra erano serrate, gli occhi spalancati avevano la stessa espressione che da vivi, lo sguardo era tranquillo e deciso, dalla fronte usciva la punta del lungo spunzone d’acciaio.”
Da questo sguardo il viaggiatore ottiene la riprova che l’individuo non ha trovato redenzione.
Ecco un punto di attacco critico al sistema, fortissimo nel pensiero di Kafka, che anche in questo racconto rivela pur non passando dall’identificazione con la vittima la sua grande anima anarchica. Anzi, la novità della scrittura di questo racconto consiste nell’assumere il punto di vista dell’osservatore, diciamo così, “fuori pericolo”. Eppure anche nella figura dell’ufficiale egli recupera l’individuo come sostanza del giudizio.
Quindi non siamo alla morte del mostro e al trionfo dell’umanità sulla crudeltà. Infatti questa storia ha un epilogo.
Dal momento in cui l’ufficiale ha fatto liberare il prigioniero e si è denudato a sua volta, liberando se stesso prima dei segni del potere e quindi della propria vita, il viaggiatore ha cominciato a notare che né il soldato né il condannato stanno più al proprio posto e comunque, solo dopo comandi, minacce, intimidazioni ubbidiscono appena.
Dopo la morte dell’ufficiale il viaggiatore si reca al porto, accompagnato sempre dai due che gli scodinzolano attorno. E’ evidente che non sanno né leggere né scrivere, e appena parlare forse. Lo guidano dentro ad un locale, una specie di bettola, dove stanno seduti uomini dalle barbe lucide, santi bevitori, apostoli analfabeti, popolo umiliato.
Spostando il tavolo scoprono la tomba del vecchio capitano con la pietra tombale e una scritta.
“Era una pietra semplice, abbastanza bassa tanto da stare nascosta sotto il tavolo. Portava una scritta a caratteri piccolissimi; per leggerli dovette inginocchiarsi il visitatore. Essa diceva: ‘Qui giace il vecchio comandante. I suoi seguaci che adesso non possono portare nessun nome gli hanno scavato questa fossa e posta questa lapide. Esiste una profezia per cui dopo un certo numero di anni il capitano risusciterà e guiderà i suoi seguaci alla riconquista dell’isola, partendo da questa casa. Abbiate fede e attendete!’. Quando il viaggiatore l’ebbe letta e si fu alzato, si guardò attorno e vide gli uomini in piedi che ridacchiavano, come se avessero letto la scritta assieme a lui, l’avessero trovata ridicola e lo incitassero a condividere la loro opinione. Il viaggiatore fece finta di non averlo notato, distribuì delle monete, attese finché il tavolo non fu rimesso sulla tomba, lasciò la Casa del Thè e si diresse al porto”.
Anche questo popolo dalla camicia a brandelli non sa leggere, forse non sa neanche parlare: esso comunica i suoi sentimenti tramite l’espressione del volto, come in un film muto o in un sogno, dove le figure parlano uno slang incomprensibile mentre la loro fisicità ti accerchia e ammiccamenti strani tendono a coinvolgerti in una tacita intesa. Il viaggiatore –che sa leggere- ha capito esattamente la profezia, come chi sa decriptare capisce un vecchio rotolo sacro. Attorno a lui un popolo analfabeta sta solo mimando delle reazioni che vogliono adeguarsi alla “sua” reazione. Se il viaggiatore sorridesse loro e si sedesse a bere una tazza di thè al tavolo con loro, ne potrebbe diventare il capo e complice sulla base di quella vecchia scritta. Solo a questo punto il viaggiatore ha capito la potenza della scrittura e se ne ritrae. Il suo ritrarsene consiste nel non esternare sentimenti e opinioni su quella scritta che rischierebbe di diventare un patto silenzioso. Ogni patto si fonda su una scrittura e suggella la Storia successiva: chi l’accetta si muove in questo sigillo, come in una traccia. Kafka ha capito come si può fuggire da questa impronta, come si può evitare di stringere questo patto. Egli l’ha capito proprio vedendo la materializzazione della scrittura: la macchina infernale.
Se mai avesse avuto un qualche dubbio sulla potenza soggiogante e mortifera della scrittura, questa materializzazione, questo suo divenire Storia, glielo ha tolto definitivamente. Bisogna rifuggire dalla scrittura-patto, dalla scrittura-suggello, dalla scrittura-tatuaggio.
Eccezionalmente… in quanto Kafka è normalmente un torturatore, vittima e boia al contempo,come lo era tanta cultura mitteleuropea. Questa eccezione forse la dobbiamo a Loos, al suo sistemare in uno schema banale quello che invece Kafka sentiva come segreto e da trattare con circospezione. Forse fu proprio questa impudica semplificazione del fenomeno grafico, ridotto a viva forza nella categoria dell’ornato, che lo fece ribellare: egli rovesciò lo schema e, avendo capito le ragioni della scrittura, non vi aderì. L’acribia descrittiva lo dimostra. Egli ripercorre scritturalmente con minuzia la materialità dei fenomeni e vi si sofferma, testardo. Tutto quanto descrive assurge a eguale importanza, come se un sensore, tastando un paesaggio scabro, ne rivelasse accuratamente tutte le asperità, lasciandoci però l’impressione dello squallore e dell’indifferenza, ché se una scrittura non si abbandona a certe preferenze, non posa l’accento su certune più che su cert’altre asperità, rende tutto uguale come la superficie di una spugna.
“Ich… las dort meine schmutzige Geschichte in vollständiger Gleichgültigkeit, kein leeres Ofenloch kann kälter sein“.
Ma la mia sporca storia è anche la mia visione della Storia ed io sono aperto ad essa con la stessa indifferenza di un forno vuoto. Un forno aperto e gelido, totalmente indifferente a ciò che vi verrà gettato dentro. L’insensibile ruvidità che ci colpisce nella prosa di questo racconto è totale disamoramento, disincanto e disinganno da qualsiasi scrittura che sia complice della Legge fatta Storia o della Storia fatta Legge (questo sì che è un rapporto biunivoco!). Kafka ha capito come la grande diatriba umana consista da sempre nell’aderire ad una piuttosto che ad un’altra scrittura della Storia.
Il vecchio capitano è appena sotto terra ed è già un mito, e la sua scrittura “cieca” ne moltiplica e ne eternizza l’operato. Tutto ciò spaventa enormemente Kafka. Lo spaventa l’idea che ci siano uomini pronti ad adorare o a denigrare il vecchio sepolto, lo spaventa l’idea che su quella lapide qualsiasi ribaldo può appoggiarsi per rilanciare la Storia.
E per questo il viaggiatore aspetta, vigile e circospetto, finché il tavolo non venga rimesso a coprire completamente la pietra tombale con la scritta profetica, e poi scappa via da quel luogo di materializzazioni della scrittura.
Ma i due lo seguono lungo la scalinata che conduce al porto. Egli sale rapido sulla barca e i due vogliono, anch’essi, saltarvi dentro
“…ma il viaggiatore sollevò un pesante canapo coperto di nodi e con esso li minacciò, e li trattenne così dal salto.” Un canapo adorno di nodi: ein schweres geknotetes Tau. Tau come tatuaggio. Egli li minaccia con un tatuaggio.
-------------
Nino Muzzi è germanista e semiologo, si occupa di formazione degli
insegnanti di tedesco e insegna alla SSIS di Firenze. Scrive di argomenti
legati alla semiotica del mondo politico nella rivista "Rocca" e sta
lavorando ad un progetto molto affascinante dal titolo "Il volto pubblico"
che forse diventerà un libro. Ha pubblicato "Materialità ecologica e
sviluppo sostenibile" per l'IRRES di Perugia, "Erich Muehsam, dal cabaret
alle barricate" in collaborazione con il suo amico A. Fambrini con il quale
ha lavorato anche ad un' antologia di scrittori del cabaret anarchico
tedesco prima dell'avvento di Hitler che uscirà presto per gli stessi tipi
della casa editrice Eleuthera di Milano.

