 |
 |
|||

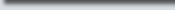
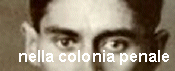
Un enigma di nome K
Enrico Carosio
Esce il libro su Kafka, il libro di Calasso su Kafka... Fremiti e brusii s'infittiscono, nel demi-monde delle lettere italiane: come sarà l'incontro tra questi due cervelli, quanto zolfo crepiterà per sfregamento di sinapsi? Calma. I pompieri chiamiamoli (chi può escludere l'incendio), ma si corregga subito l'informazione falsa. Non è il libro di Roberto Calasso su Kafka. È il libro di Calasso su K. Il titolo è "K." (Adelphi, 360 pagine, 18,50 euro, in uscita il 9 ottobre), e sarebbe grave non prenderlo alla lettera. Come sarebbe grave non cogliere che in questa ricostruzione indiziaria di K., chiunque egli sia, non compare l'aggettivo «kafkiano», che Calasso ritiene tra i più kitsch del Novecento.
Quarto volume di una tetralogia provvisoria, "K." è un libro di un'intelligenza che spaventa e ogni tanto confonde. A tratti il dialogo serrato tra l'autore e i testi di Kafka suona come un duetto di jazz contaminato, Coltrane che incontra Ravi Shankar. E tuttavia è il libro più luminescente che Calasso abbia scritto. Non è una monografia, né un'interpretazione, né un racconto, se non il racconto delle storie scritte da Kafka, lo struggente autore della modernità. Che cos'è allora? Forse una illuminazione. Aver letto "K." è come essere entrati nell'acqua nera del mare in una notte di luna, aver agitato le mani sotto la superficie e aver visto scintillare tutta l'iridescenza del plancton. Ma appena le mani si sono fermate le acque sono tornate nere com'erano prima di entrarvi. Nessuno che ami Kafka (che è come dire: il Novecento) potrà aggirare questa narrazione.
Per Elias Canetti l'autore del "Processo" fu il più grande esperto di "Macht": che non è potere; è anche potenza, chiosa Calasso. «Kafka intuì che del mondo circostante ormai andava nominato il numero minimo di elementi», avverte l'autore dopo poche righe: «Perché il mondo tornava a essere una foresta primordiale, troppo carico di suoni ignoti e apparizioni. Tutto aveva troppa potenza».
Kafka, ci fu insegnato, è il narratore della colpa e dell'innocenza, dell'io schiacciato dal progresso, l'anticipatore dei lager e dei gulag, l'esistenzialista, il teologo, l'angelo, il santo, l'uccisore di tutti i padri. Canetti tagliò corto: «Ci sono certi scrittori che sono così totalmente se stessi che qualsiasi dichiarazione su di loro uno si arroghi, potrebbe sembrare una barbarie». Calasso lo prende in parola. La sua lettura è autosufficiente, non si confronta più con quello che su Kafka da mille penne è stato scritto. La lettura psicoanalitica, per esempio, non c'è: per Calasso Kafka comincia dove la psicoanalisi finisce. Le venti pagine di fonti, in appendice, sono quasi solo citazioni dai testi. Più d'una, invece, l'insolenza contro Max Brod, l'amico praghese che ha il merito storico, disobbedendo al testamento, di aver salvato dalla distruzione l'opera di Kafka, e che Calasso tratta come uno psicologo «da periodici femminili». Lo fa a pagina 332, di nascosto, ma si nota lo stesso.
"Il Castello" e "Il processo" sono le montagne che l'autore attraversa in un milione di cunicoli. «Ignoti si presentano nella camera da letto di Josef K., divorano la sua prima colazione e gli notificano che un procedimento penale è in atto contro di lui». Situazione-madre che gemma situazioni-figlie innumerevoli. Calasso ne sviscera a decine. Parte da un episodio minimo e racconta perché gli ignoti «divorano» e non «mangiano», e le divagazioni zoomorfe s'intrecciano, dalla creatura indefinita della "Tana" ai topi di "Josefine" all'archetipo di tutti, l'insetto, il coleottero della "Metamorfosi", che in tedesco è "Ungeziefer", parassita sinistro e intraducibile. Calasso ci conduce tra gli asfittici spazi mentali della colpa, della legge, dell'ordine. Come ci aveva condotto intorno al tema della legittimità nella "Rovina di Kasch", il più impervio dei suoi libri.
Da vent'anni Calasso è incatenato alla propria opera circolare, un eterno ritorno dell'analogo: "Kasch" (1983) trattava, come scrisse Calvino, «per metà di Talleyrand e per metà di tutto il resto», una drammaturgia del potere a cavallo del Congresso di Vienna, ed è un libro sperimentale, basato su diversi registri narrativi; "Le nozze di Cadmo e Armonia" (1988) raccontava la Grecia attraverso i miti, ed è la pura ipnosi del narrare; "Ka" (1996) indagava l'India attraverso i miti, ma alla narrazione accompagna la speculazione. "K.", infine, riduce lo sguardo dalla forma illimitata delle storie che generano storie a uno spiraglio, alla cruna di un ago. Kafka a Brod, nel 1922: «Già il campo visivo qui dalla mia finestra è per me troppo vasto».
Condannato nel "Processo", ucciso dai due sicari che gli rigirano due volte un coltello nel cuore, Josef K. riappare sotto il nome K. nel "Castello", il romanzo che sta al centro dell'indagine calassiana. K. è l'eroe, e diciamo eroe per pura comodità, di un mondo intermedio dove i signori sono arconti, e i servi sono servi, i funzionari l'ordine, lo straniero il disordine. Quel mondo che nel Libro Tibetano dei Morti è il "bar-do". O nella dottrina dell'India antica è il confine tra "avyakta" e "vyakta", le parti immanifesta e manifesta del brahman. Qui Calasso, da scrittore, ci lancia il segnale che "K." è legato in vari punti al precedente "Ka". E da studioso suggerisce che se "Il Castello" sembra scritto come un romanzo di Dickens o di Dostoevskij (Kafka amava molto questi narratori classici, mentre aveva poco interesse per quelli fantastici alla Poe o alla Kubin), «la differenza sta nel luogo» dove tutto si svolge. Ecco il punto in cui Calasso, anche se lo nega, dà una sua interpretazione di Kafka: «Nessuno si era azzardato a scrivere un romanzo su quella linea di confine».
È forse la linea su cui sta a cavalcioni il colonnello Kurtz quando pronuncia «the horror», l'orrore, prima in Conrad, poi in "Apocalypse Now". Kafka non poteva sapere di Marlon Brando, sebbene fosse un anticipatore prodigioso. Calasso stesso ne parla poco, forse perché gli pare ovvio, ma "Nella colonia penale", "La metamorfosi", "Il processo" sono già arredati dagli scenografi di Himmler o della Lubjanka. Nel "Verdetto", racconto dalla trama assurda che non finiremmo mai di rileggere, si accenna (nel 1912!) a «rivoluzioni russe», e s'intravede in filigrana non solo Freud, o Ferenczi, ma Stan Laurel. Così come nel "Disperso" (titolo definitivo di "America"), il terzo romanzo, si respira Chaplin, il musical, la New York delle tavole di Little Nemo, che Kafka ingnorava. E chi è la ballerina Brunelda («Era tutta da leccare. Era tutta da bere») se non una femmina felliniana?
Alle donne, anzi a "La via delle donne", è dedicato un capitolo meraviglioso. Calasso le spia, le denuda, le odora, le assaggia insieme a K. Si chiamano Frieda, Pepi, Olga, Leni, «questi esseri femminili bisillabici, subalterni, erotici». Per K. sono veicoli di conoscenza, specchi della propria colpa, monete di scambio. Secondo Talleyrand (ancora dalla "Rovina di Kasch"), per ottenere un risultato occorreva «faire marcher les femmes», mandare avanti le donne, e pensava a Madame de Staël che agiva per lui. K. vuole Frieda, l'amante del funzionario, per accedere al Castello.
K. è condotto nel mondo dalle donne, non diversamente dagli eroi della Grecia tra Arianna, Calypso, Fedra e le Danaidi. Ed è formidabile come Calasso ci faccia perdere tra quelle sottane, tra quei profumi di corpi, in quelle stanze anguste e surriscaldate dove K. naufraga a ripetizione, seduto sui bordi dei letti, immerso in cuscini materni ad ascoltare i prologhi delle sue dannazioni. Calasso legge un'eco femminile passabilmente perversa persino nei «fazzoletti per signora» che l'ufficiale della «Colonia penale» s'infila sotto il colletto, nella calura di un triste tropico, mentre spiega il meccanismo dell'erpice torturatore. Macchina celibe che Kafka s'inventò non si sa come, giacché si colloca tra Duchamp e il dottor Mengele. E sulla quale Calasso si dilunga poco, quasi fosse troppo anche per lui, quasi temesse che "L'Osservatore Romano" gli rinfacciasse, dopo l'empietà, chissà, il voyeurismo o il vizio di collezionare Klossowski.
Difficile scegliere, in un libro così ricco di osservazioni. Ce n'è per tutti: l'irruzione del comico, l'ebraismo dell'assimilato, l'eros della legge, la nozione di sacrificio, le forme dell'assoluzione secondo il Titorelli del "Processo", l'arduo penultimo capitolo (da pagina 297) sugli interrogatori notturni nel "Castello". Quello in cui K. arriva vicino alla verità, ma è vinto dal sonno perché «il Castello è mite e comprensivo soltanto verso chi è già esausto».
Per finire. C'è un gioco di società che "K." porta con sé inevitabilmente. Perché la sillaba "ca" o "ka" appare in tutt'e quattro i titoli della tetralogia (K in tedesco si pronuncia "ka") oltre che nel suo nome? Calasso giura che è puro caso. E noi non gli crederemo. Ricordando come amici turpi l'avessero ribattezzato, anni fa, con un nome da furfante, Robert Gottlos von Calypso (Gottlos sta per: senza Dio).
© L'Espresso, 10.10.2002

